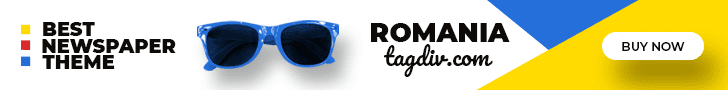Questo articolo è stato pubblicato da questo sito
Dopo mesi di blocco quasi totale all’ingresso nella Striscia di Gaza degli aiuti umanitari imposto da Israele (l’ordine risale al 2 marzo 2025), la parziale ripresa delle consegne attraverso canali controllati dall’esercito israeliano non è riuscita a scongiurare una crisi umanitaria di proporzioni drammatiche.
Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute di Gaza, dall’inizio della guerra si registrano 147 persone morte per malnutrizione, di cui 88 sono bambine e bambini sotto i cinque anni. Di fronte a questo tracollo della situazione, l’esercito israeliano ha ceduto alle pressioni internazionali. Il 27 luglio Tel Aviv ha annunciato l’avvio di una pausa tattica quotidiana per consentire la distribuzione di aiuti umanitari, prevista dalle 10 alle 20, ora locale, che prevede l’ingresso di circa 300 camion carichi di viveri e beni di prima necessità nelle tre aree più densamente popolate della Striscia.
Ma la misura resta largamente insufficiente: secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa), per soddisfare i bisogni essenziali degli oltre 2 milioni di abitanti servirebbero tra 500 e 600 camion al giorno, vale a dire circa il doppio.
Le cifre insufficienti della pausa umanitaria
L’agenzia israeliana Cogat, che coordina le attività nei territori palestinesi occupati dal 1967, ha comunicato che nel primo giorno di pausa sono stati distribuiti i carichi di 120 camion, mentre nelle ore successive ne sono entrati altri 180 attraverso i varchi presenti ai confini controllati dalle forze israeliane. Prima del blocco totale, circa 500 camion attraversavano quotidianamente i checkpoint verso Gaza. La popolazione della Striscia, infatti, era già soggetta di un blocco parziale in vigore dal 2007 che ha condizionato lo sviluppo dell’economia locale e la libertà di movimento.
Nonostante gli appelli dei leader palestinesi a mantenere l’ordine, molti dei camion sono stati presi d’assalto da migliaia di civili affamati, secondo quanto riportato dal Washington Post. La disperazione ha impedito che gran parte degli aiuti raggiungesse le tre aree principali della Striscia, dove si concentra la maggior parte della popolazione sfollata. Questi episodi riflettono una situazione di fame estrema, in netto contrasto con la narrazione israeliana che attribuisce ad Hamas la responsabilità del controllo e della sottrazione degli aiuti come giustificazione per la loro limitazione o blocco. Ma due indagini indipendenti — una dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid) e una condotta dallo stesso esercito israeliano (Idf) — hanno escluso il verificarsi di appropriazioni sistematiche da parte di Hamas. Dei 156 episodi analizzati, in 44 casi la responsabilità dei furti è stata ricondotta direttamente alle forze israeliane.
Le pressioni internazionali
La decisione israeliana di autorizzare questa limitata ripresa delle consegne è arrivata dopo settimane di crescenti pressioni diplomatiche da parte degli Stati Uniti e dell’Unione europea. Il segretario di Stato americano Antony Blinken aveva intensificato i contatti con il governo israeliano dal mese di giugno, mentre il Consiglio di Sicurezza dell’Onu aveva approvato l’8 luglio una risoluzione che chiedeva l’accesso umanitario immediato e senza ostacoli alla Striscia. Queste pressioni si sono intensificate dopo che diversi paesi donatori avevano minacciato di rivedere i loro programmi di cooperazione militare con Israele. Tuttavia, anche con le pressioni internazionali, la distribuzione rimane a dir poco insufficiente e complessa. Le Nazioni Unite hanno denunciato che i camion delle loro agenzie rimangono bloccati per ore prima di ottenere l’autorizzazione a passare dai checkpoint israeliani di Kerem Shalom ed Erez, gli unici due valichi operativi dopo la chiusura di quello di Rafah, al confine con l’Egitto, avvenuta il 7 maggio scorso durante l’offensiva israeliana nella città meridionale. L’Ocha, l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, ha documentato come questi ritardi amministravi abbiano ridotto del 60 per cento l’efficacia della distribuzione rispetto ai livelli pre-conflitto.
Sempre domenica 27 luglio, per la prima volta da aprile, sono ripresi anche i lanci degli aiuti per via aerea: circa 25 tonnellate di cibo sono state paracadutate da velivoli dell’aviazione israeliana. Ma secondo Philippe Lazzarini, direttore dell’Unrwa, si tratta di una misura più simbolica che utile, perché il trasporto via terra risulta dieci volte più efficiente ed economico, secondo le stime dell’agenzia stessa. Anche un’analisi di Bbc verify ha sollevato dubbi sull’efficacia dei lanci: alcuni sono avvenuti nei pressi di Beit Lahia, un’area del nord della Striscia di Gaza ancora soggetta all’ordine di evacuazione da parte dell’esercito israeliano. Attualmente, l’88 per cento del territorio della Striscia è stato ufficialmente designato come zona di combattimento o evacuazione.