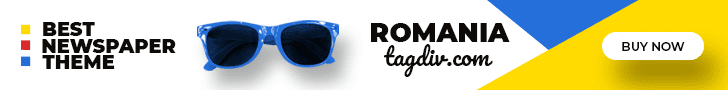Questo articolo è stato pubblicato da questo sito
Le droghe sono presenti da sempre nella storia e nella letteratura. E se pensiamo che siano stati i poeti maledetti a scoprire il richiamo di queste sostanze nell’Ottocento, o ancora più tardi musicisti degli anni Sessanta desiderosi di “aprire la mente”, sbagliamo di grosso. Erodoto nel V secolo a.C. raccontava l’uso che il popolo degli Sciti, nomadi delle steppe iraniche, faceva della cannabis: l’intento era, secondo lo storico (anima candida), finalizzato all’igiene personale, ma il risultato andava decisamente oltre. Per pulirsi il corpo, gli Sciti costruivano una specie di tenda con coperte di lana e al suo interno arroventavano pietre poste in una conca: «dopo aver preso i semi di questa cannabis, si infilano sotto le coperte e poi gettano i semi sulle pietre roventi. Il seme gettato fa fumo ed emana un vapore tale che nessun bagno a vapore greco potrebbe vincerlo. Gli Sciti mandano urla di gioia, felici per questo bagno di vapore».
Questa è considerata la prima testimonianza letteraria dell’uso della cannabis (il nome greco era lo stesso) per fini ricreativi. In realtà la pianta era usata in Oriente, ma anche nel mondo classico, con scopi terapeutici; davvero curiosi sono gli usi suggeriti da Plinio il vecchio nella sua Naturalis Historia: «Si dice che i semi di cannabis distruggano lo sperma. Il succo che si ricava da questa pianta fa espellere i piccoli vermi delle orecchie e qualunque altro parassita che si annidi in esse, ma provoca il mal di testa, ed ha tanta forza che versato nell’acqua la fa coagulare; è anche per questo che bevuto in acqua reca giovamento al ventre nelle bestie da soma. La radice, bollita in acqua, scioglie le articolazioni contratte, e cura la gotta, come pure attacchi simili. Sulle ustioni si applica cruda, ma cambiandola spesso, prima che si asciughi». Meglio evitare di provare a casa. Non va dimenticato l’oppio, il cui nome greco significa semplicemente “succo”: l’estratto di papavero era usato spesso in medicina, ed è alla base di quella nepente che Elena versa, secondo Omero, nei calici alla corte di Menelao per rilassare gli ospiti. E il papavero è spesso raffigurato nelle mani di Morfeo, dio del sonno.
Oracoli e visioni
Ma forse prima ancora che come medicina, le droghe erano impiegate da sacerdoti, indovini e “maghi” per vaticinare e facilitare la comunicazione con il divino. Così la Pizia, sacerdotessa di Apollo, secondo Plutarco, pronunciava i suoi responsi dopo essersi ritirata in una cella dove inalava un gas dolciastro, emanato da una sorgente sotterranea. Il gas provocava uno stato di trance talmente profondo da portare al delirio e, in alcuni casi, alla morte: si trattava, secondo alcuni, di etilene. Non era certo un caso isolato: pare che i Magi in Oriente assumessero l’erba theangelis prima di divinare. Molto lontano da qui, nello spazio ma anche nel tempo, si collocano le visioni dei Nativi Americani: il peyote, per esempio, derivato da un cactus, stimolava attraverso la mescalina una sensazione di benessere accompagnata spesso da allucinazioni. Allucinazioni erano provocate, durante il medioevo, in Europa, da erbe stupefacenti, dalla segale cornuta alla cicuta, dalla belladonna al papavero: queste, spesso mischiate tra loro, erano sovente connesse agli episodi di “stregoneria”, utilizzate nei sabba e nei raduni delle streghe. Ma proprio nei cosiddetti “secoli bui”, che bui non erano poi tanto, l’attività dei monaci portò a conoscere più a fondo le proprietà di queste ed altre sostanze. Gli studi dei frati sono descritti in maniera puntuale da Umberto Eco ne Il nome della rosa: Severino, l’erborista del convento, illustra a Guglielmo e al giovane Adso le proprietà medicinali e curative di molte piante. E non solo quelle. Alla domanda del ragazzo che gli chiede quali erbe provocano cattive visioni, Severino risponde: «eh eh, il nostro novizio vuole sapere troppo. Queste sono cose che deve sapere solo l’erborista, se no qualsiasi sconsiderato potrebbe andare in giro a somministrar visioni, ovvero a mentire con le erbe».
I grandi autori
Dalle visioni rituali all’ispirazione artistica il passo è breve. Così nell’Ottocento romantico si diffuse tra scrittori e poeti una vera e propria moda: Baudelaire, Verlaine, Coleridge, Poe, Shelley, Keats, Scott sono solo alcuni dei nomi più illustri che si possono ricollegare all’uso di stupefacenti, senza dimenticare l’italianissimo D’Annunzio. E se i “poeti maledetti” ricorrevano all’oppio e all’assenzio per creare i loro “paradisi artificiali”, i romanzieri hanno voluto inserire nella loro opera personaggi che, in modo più o meno palese, fanno uso di droghe. Così Dumas racconta come il Conte di Montecristo, reduce da anni di viaggi in Oriente, avesse imparato non solo a servirsi di erbe, medicamenti e veleni, ma anche a domare i propri demoni con l’aiuto dell’hashish. Un altro famosissimo personaggio letterario ha grossi problemi di dipendenza: Sherlock Holmes aiuta la sua brillante mente con l’uso della cocaina, che gli porta però allucinazioni e periodi di completa apatia. L’uso di droga era, secondo alcuni commentatori, alla base delle trasformazioni del dottor Jekyll in Mr. Hyde: la pozione che beveva altro non era che un allucinogeno. Di certo a fare uso di sostanze era il suo creatore, Stevenson. Non c’era consapevolezza di quanto le droghe potessero far male. Ma ci furono anche autorevoli voci capaci di denunciare i pericoli delle droghe. Tra queste, quella di Balzac, che nel Voyage de Paris à Java così scriveva: «L’oppio assorbe tutte le energie umane, le convoglia in un punto solo, le prende, le sviluppa al quadrato o al cubo, le eleva a non saprei quale potenza, e consente a tutto l’essere una creatività nel vuoto. Fa conferire a ogni senso il maggior piacere possibile, lo stimola, lo stanca, lo consuma; pertanto l’oppio è una morte certa».