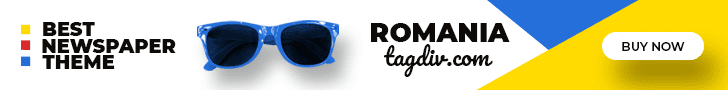Questo articolo è stato pubblicato da questo sito
Pochi sono i Paesi dell’UE che stanno provando a dimezzare l’uccisione, il prelievo e il commercio illegale di uccelli entro il 2030, come chiesto dalla Convenzione di Berna e dal Piano strategico di Roma 2020-2030 della Convenzione sulle specie migratorie. E l’Italia non è tra questi, neanche quest’anno.
Secondo il nuovo report The Killing 3.0 di BirdLife International e EuroNatur, il nostro Paese risulta infatti nuovamente il peggiore e continua a conservare gelosamente le proprie tradizioni illegali come le trappole (reti, vischio, trappole a scatto) e i richiami sonori che sterminano regolarmente tordi, pettirossi e altri piccoli uccelli migratori. Dal 2017 al 2023, secondo Ispra, di quelli che hanno malauguratamente deciso di sorvolare il nostro territorio ne abbiamo uccisi oltre 32 milioni, solo nella stagione di caccia 2022/2023 5,6 milioni.
Queste cifre pongono l’Italia in prima posizione tra i campioni di caccia illegale – seguita da Egitto (5,4 milioni), Siria (3,9 milioni) e Libano (2,6 milioni) – ma soprattutto chiedono a tutti i Paesi coinvolti “un’azione transfrontaliera più forte e coordinata lungo tutto il percorso migratorio”. Secondo Justine Vansynghel, ricercatrice ed esperta di Euronatur “raggiungere l’obiettivo per il 2030 è una grande sfida, ma non è ancora impossibile”. Wired Italia l’ha incontrata per scoprire se e come le nuove tecnologie possono essere di aiuto e a chi. Se ai cacciatori illegali o a chi li vuole bloccare.
Sensibilizzazione 2.0
L’utilizzo di strumenti digitali a scopo di sensibilizzare e comunicare, pur essendo quello più ovvio e apparentemente “banale”, può dare grandi soddisfazioni. Vansynghel ne è convinta e cita la campagna “Flight for Survival” che sfrutta i social media per educare il pubblico sulle uccisioni illegali di uccelli, con contenuti mirati per paesi ad alto rischio. Esistono anche alcuni progetti pilota che utilizzano la realtà aumentata per mostrare virtualmente l’impatto del fenomeno sugli ecosistemi o app che trasformano i cittadini in piccole vedette anti-caccia illegale. La logica è simile a quella della citizen science: chi nota attività sospette in tempo reale può segnalarle con un tocco sullo schermo.
Un grande contributo al contrasto dei fenomeni illegali arriva anche da parte degli strumenti usati per osservarlo. Che siano satellitari o aeree, termiche o da drone, le immagini sono sempre preziose ma lo sono anche per chi commette il crimine. “I droni ci aiutano a monitorare aree remote o difficili da raggiungere, come le zone umide o le isole, a Malta, per esempio, questa tecnologia ha dato ottimi risultati- spiega Vansynghel – purtroppo non sempre è possibile utilizzare questi dispositivi perché vietati dalle norme vigenti in una certa area. Inoltre fanno un rumore che mi rende facilmente identificabili dai cacciatori illegali”. Anche la termocamera può essere un’ottima alleata per, “soprattutto di notte, per identificare dove sono posizionati i cacciatori ma purtroppo è usata anche da loro per scoprire dove siamo noi o le forze di polizia” racconta Vansynghel.
Dati migratori per uccelli migratori
Sia droni che termocamere sono armi a doppio taglio: dipende chi le impugna. Per compiere un passo avanti, chi contrasta le uccisioni illegali di uccelli dovrebbe puntare sui database condivisi, realizzando una piattaforma per centralizzare tutte le informazioni utili e favorire la collaborazione transnazionale per monitorare le tendenze e coordinare le azioni. Il report Killing 3.0 è un esempio di quanto possa essere utile far convergere i dati di tanti Paesi ma anche di quanto sia complesso farlo. “I dati non sono raccolti in modo omogeneo nei vari Paesi e mancano gli standard anche nelle stesse definizioni e nelle unità di misura – spiega Vansynghel – è stato un lavoro sfidante ma speriamo sia un apripista e uno standard di riferimento per i prossimi 10 anni”.