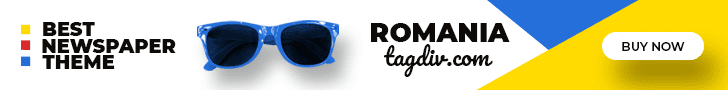Questo articolo è stato pubblicato da questo sito
Il primo passo per scoprire se esistono forme di vita aliene nell’Universo è decidere su quale esopianeta cercarle. Non tutte le stelle, d’altronde, hanno pianeti che gli orbitano intorno. Non tutti i pianeti presentano le condizioni necessarie per ospitare la vita, almeno per come la conosciamo. E ancor meno sono sufficientemente vicini alla Terra da poter immaginare di studiarli in prima persona: un particolare non da poco, visto che qualunque tipo di indizi raccolto con analisi a distanza andrebbe comunque confermato inviando una sonda in loco, prima di poter dire con certezza di aver scoperto una forma di vita aliena.
la forma dei telescopi e gli esopianeti
Per trovare pianeti del genere, i cacciatori di esopianeti tradizionali non sono sufficienti: anche telescopi di successo come l’ormai decomissionato Kepler della Nasa, con cui sono stati scoperti più di metà di tutti gli esopianeti oggi conosciuti, sono estremamente inefficienti per lo studio accurato del nostro “vicinato galattico”. E molte delle missioni proposte per superare il problema richiederanno tecnologie e capacità tecniche ancora tutte da sviluppare. Un team di ricercatori del Rensselaer Polytechnic Institute e del Goddard Space Flight Center della Nasa ritiene però di aver trovato una soluzione: un telescopio spaziale con caratteristiche molto simili a quelle del telescopio James Webb, che al posto del tradizionale specchio circolare ne presenta uno di forma rettangolare e allungata.
Un design imperfetto
Osservare un pianeta posto a decine, se non centinaia o migliaia, di anni luce dal nostro è un lavoro estremamente complicato. Ogni pianeta, d’altronde, orbita attorno ad una stella che emette una luce milioni di volte più forte di quella che può riflettere verso di noi un ammasso di roccia e acqua, per quanto grande esso sia. I telescopi spaziali utilizzati per la caccia agli esopianeti solitamente aggirano il problema sfruttando un trucco: invece di cercare di osservare direttamente la presenza di corpi celesti, la inferiscono registrando i lievissimi cali di luminosità che questi causano quando passano direttamente davanti alla loro stella.
Il metodo funziona: in poco meno di 10 anni di attività, Kepler ha permesso di individuare oltre 2.800 esopianeti, sui 5.600 oggi presenti negli archivi della Nasa. Pur rivelandosi quindi molto efficace nel trovare esopianeti guardando all’immensità dello Spazio, il “metodo del transito” non offre molta precisione. Tutt’altro: può individuare solo una frazione minima degli esopianeti presenti in una data porzione di cielo, perché ha un requisito molto particolare per poter funzionare. Per ridurre la luminosità della propria stella, infatti, un esopianeta deve trovarsi su un’orbita perfettamente allineata con la nostra linea di vista. E se lo scopo è trovare esopianeti attorno alle circa 60 stelle situate entro 30 anni luce dalla Terra (una distanza che renderebbe non facile ma almeno plausibile inviare una sonda per verificare la presenza di forme di vita aliene), è chiaro che in questo modo ne sfuggono troppi per poter risultare affidabile.
Nuove strategie
I telescopi pensati per lo studio “a transito” degli esopianeti rimangono estremamente utili, e infatti il successore di Kepler, battezzato Tess, è già al lavoro dal 2018 e ha completato due round di osservazioni. Ma per mappare con cura il nostro vicinato galattico serve una tecnologia diversa. Una possibilità è quella di sfruttare il cosiddetto metodo della velocità radiale, ossia utilizzare degli spettrometri per misurare le piccolissime oscillazioni nell’orbita di una stella provocate dalla presenza di un pianeta. Richiede però tempi di osservazione molto lunghi, e come per il metodo del transito ha un punto cieco: in questo caso, pianeti che orbitano con un piano perpendicolare alla nostra linea di vista, situazione in cui non producono oscillazioni nell’orbita della stella che risultino rilevabili dalla nostra posizione.
Per raggiungere una mappatura ancora più accurata, la cosa migliore sarebbe poter studiare le stelle nelle nostre vicinanze con strumenti di imaging diretti, e senza dover fare ricorso a metodi indiretti come quelli appena descritti. Il problema è che, come dicevamo, la liminosità di un pianeta è pressoché nulla rispetto a quella della sua stella. E per distinguerlo serve quindi una risoluzione elevatissima: per sistemi stellari posti a 30 anni luce dalla Terra, un telescopio a infrarossi avrebbe bisogno di uno specchio con un diametro di 20 metri per riuscirci. Per lanciare nello spazio James Webb, che ha uno specchio di poco più di sei metri, sono serviti decenni di studi e preparazione, e un meccanismo di autoassemblamento talmente complicato che fino all’ultimo gli stessi scienziati della Nasa non erano certi avrebbe funzionato. E quindi per ora, un telescopio spaziale di 20 metri non è un’opzione.