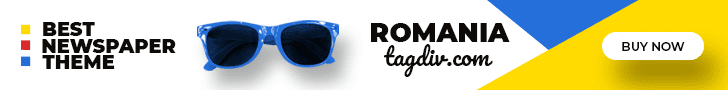Questo articolo è stato pubblicato da questo sito
Nel nostro lavoro, questo significa costruire pipeline analitiche che ricostruiscono milioni di conversazioni, osservano flussi informativi in tempo reale, identificano polarizzazioni latenti, mappano reti di amplificazione. La domanda giusta non è: chi ha inventato la fake news? Ma: quali condizioni strutturali l’hanno resa virale? Non: chi è il colpevole? Ma: qual è il sistema che ha trasformato un messaggio in un fenomeno sociale? È questo il cambio di paradigma: spostare l’attenzione dalla colpa alla struttura, dalla superficie al meccanismo.
Ricostruire la conoscenza
È un salto radicale. Per secoli la conoscenza si è costruita con narrazioni lineari: una causa, un effetto, un colpevole. Ma i sistemi complessi non funzionano così. Ogni elemento interagisce con tutti gli altri, le retroazioni amplificano gli effetti locali, e l’emergenza supera la somma delle parti. In questi contesti, l’intuizione fallisce. La nostra mente, evolutivamente, è programmata per riconoscere volti ed emozioni, per immaginare intenzioni dietro i comportamenti. Ma quando il sistema collassa — una borsa che crolla, un ecosistema che implode, una polarizzazione che esplode — la storia semplice che inventiamo non è una spiegazione: è un’illusione.
Per questo servono modelli, simulazioni, scenari controfattuali. Non per sostituire l’interpretazione umana, ma per correggerne i limiti. La scienza non è un oracolo, è una lente che permette di distinguere il rumore dal segnale. Senza questa lente, restiamo prigionieri delle metafore, incapaci di vedere la struttura sotto la superficie.
Ed è qui che incontriamo il vero rischio del nostro tempo: l’epistemia. La condizione in cui la fluidità del linguaggio viene scambiata per conoscenza. È lo stato cognitivo in cui ci fanno entrare i grandi modelli linguistici: macchine statistiche che generano frasi plausibili, anche quando non hanno nulla da dire. Producono la forma della conoscenza senza il suo fondamento. La credibilità senza la responsabilità. È l’illusione di sapere, che è peggiore del non sapere.
La lezione della Grande Paura allora diventa urgente. Allora i contadini vedevano briganti che non esistevano, ma la loro paura aveva radici materiali concrete. Oggi rischiamo di vedere conoscenza dove c’è solo fluency statistica, coerenza apparente senza ancoraggio alla realtà. La filosofia e le scienze sociali, se vogliono essere utili, devono smettere di giocare con metafore generiche e sporcarsi le mani con i dati. Parlare di etica dell’IA senza sapere come funziona un transformer è come scrivere trattati di medicina senza aver mai aperto un corpo.
Perché ci serve un approccio data-driven
Il problema non è la mancanza di buone intenzioni, ma l’eccesso di cattiva epistemologia. Per troppo tempo abbiamo prodotto concetti brillanti ma vuoti, acrobazie retoriche che non reggono alla prova dei dati. Abbiamo trasformato fenomeni sistemici in slogan. Ma la realtà non è un dibattito televisivo. È un sistema. E i sistemi non si commentano: si studiano.