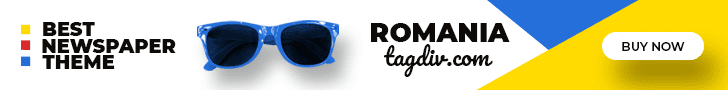Questo articolo è stato pubblicato da questo sito
Roma città aperta arriva nelle sale italiane il 27 settembre di 80 anni fa, a cui seguirà una capillare distribuzione internazionale, che ne farà uno dei titoli più fondamentali del cinema moderno, nonché il simbolo del Neorealismo. A distanza di tanto tempo, il capolavoro di Roberto Rossellini non ha perso nulla del suo valore, della sua capacità di smuovere dentro qualcosa di potentissimo.
Un capolavoro che cambia il legame tra realtà e finzione cinematografica
Roma città aperta debutta nei cinema quando l’eccidio su scala mondiale è ufficialmente terminato meno di quattro settimane prima. L’Italia è in macerie, letteralmente in ginocchio. Fame, miseria, incertezza e dolore sono il pane quotidiano, da nord a sud il paese non sa quale sarà il suo futuro, sa solo che tutto è da rifondare. Roma è stata liberata agli inizi di giugno del 1944, e la settima arte ha ricominciato a muovere i primi passi. C’è un regista, Roberto Rossellini, già apprezzato negli anni precedenti, che già a fine 1944 parla spesso con gli sceneggiatori Sergio Amidei e Alberto Consiglio, e con loro concepisce il soggetto originale, che dovrebbe intitolarsi La disfatta di Satana, da dedicarsi alla figura di Don Pietro Pappagallo, tra le vittime dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Il progetto muta pelle, soprattutto quando si aggiungono come sceneggiatori, Ferruccio Disnan e un certo Federico Fellini.
Hanno idee molto diverse tra di loro politicamente, soprattutto sulla Resistenza, che Fellini reputa inutile e dannosa. Questa contrapposizione e l’evoluzione del progetto poi porterà al disconoscimento di Amidei e Disnan. Ma forse, proprio da quella fusione di differenti punti di vista, nasce in Rossellini ciò che renderà il film così unico ed universale. Il regista per un istante pensò anche di fare un altro documentario, intitolato Storia di ieri, dedicato ad un’altra figura religiosa cara alla Resistenza: Don Giuseppe Morosini. Poi però si decide di fare un film, un vero film, recuperando elementi suggeriti da fatti reali, veri personaggi, veri drammi della Caput Mundi in attesa di una liberazione che non arrivava mai. Roma città aperta viene girato con mezzi di fortuna e pellicole pescate un po’ dovunque, il budget è a dir poco limitato, senza l’aiuto fondamentale di un commerciante di lana chiamato Aldo Venturini, il film morirebbe sul più bello.
La Roma del marzo del 1944 è dove vive l’ingegnere Manfredi (Marcello Pagliero), uomo delle Resistenza che, in fuga dalle SS, trova rifugio presso Francesco (Francesco Grandjacquet), un tipografo. Questi sta per sposarsi con Pina (Anna Magnani), incinta e già madre del piccolo Marcello (Vito Annichiarico). A dar loro una mano c’è il parroco Don Pietro Pellegrini (Aldo Fabrizi), ma tutti verranno travolti dai nazisti, armati di spie e violenza. Roma città aperta non ha nulla di rivoluzionario nell’iter, ma trova nella modalità espressiva, nello stile, nella concezione cinematografica di Rossellini (più stretta possibile alla verità) una forza innovatrice capace di andare ben oltre il semplice mezzo cinematografico. Quella volontà di ancorarsi ad una realtà da ricreare con il minimo possibile di alterazione, anche politicamente avrà un impatto enorme, si tramuterà in una diversa concezione della società, della vita stessa.
Roma città aperta ci parla di un’umanità che è microcosmo rappresentativo dell’intero paese, con la fame, il terrore, ma la volontà di resistere. C’è la piccola borghesia, i ceti popolari, il clero, poi i fascisti, i nazisti, i collaborazionisti mossi dalle più varie e assurde ragioni. Grazie a loro i nazisti riescono a prendere Francesco, e quel momento drammatico, diventerà una delle scene più famose della storia del cinema, il manifesto di quel Neorealismo, che grazie a Rossellini poi diventerà fiore all’occhiello della nostra cinematografia. Anna Magnani, benché presente solo nella prima metà del film, assieme ad Aldo Fabrizi è il simbolo palpitante di Roma città aperta, la sua presenza scenica maestosa, la sua capacità di essere vera, reale, ogni volta che appare sullo schermo, si eleva in quel momento tragico e immortale, in quella morte che da ottant’anni è ormai patrimonio comune.
L’eredità di un film che ancora oggi ci rappresenta
Pina che corre, una sventagliata di mitra che la fredda, come capitò a Teresa Gullace, trucidata dai nazisti per strada. Quella scena fu girata a via Raimondo Montecuccoli, il palazzo è quello dove ho vissuto il primo anno che sono giunto a Roma. Non c’è nulla fuori oggi, solo un pannello malmesso per celebrare quella corsa, Anna Magnani cade (in realtà inciampò e finì a terra prima del previsto). La decisione di Rossellini di tenere quella sequenza, è coerente con la volontà di aver un rapporto intimo con lo spettatore, basato sulla verosimiglianza. Il suo cinema vuole parlarci di qualcosa di universale e allo stesso tempo particolare. La Resistenza è un fenomeno che Rossellini descrive come istintivo, si fonda sull’empatia, sulla solidarietà tra ultimi nella capitale che aspetta di essere salvata. Roma, fateci caso, è l’unica capitale occupata europea e l’unica città italiana rilevante che non risponderà alla chiamata alle armi.