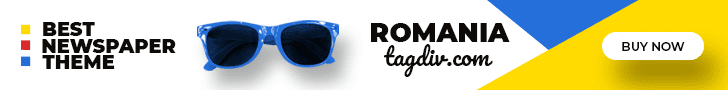Questo articolo è stato pubblicato da questo sito
L’inizio è un documentario prezioso, dicevamo, non solo per la sua fattura tecnica – un montaggio efficace ed emotivo, ma anche completista e chiaroscurale, con immagini di repertorio e interviste ai protagonisti; ma anche perché a distanza di un quarto di secolo cerca finalmente di fare il punto sulla portata epocale che lo sbarco del format Big Brother ha avuto nel nostro quadro mediatico e, se vogliamo, più genericamente culturale. Questi decenni di reality, tutti quelli che sono nati dopo ma compresa anche la deriva a dir poco triviale dello stesso GF, hanno irrimediabilmente avvelenato la nostra percezione del genere, che oggi è ridotto a una via di mezzo tra postribolo voyeuristico e malconcio ufficio di ricollocamento di personaggi semi-famosi. Oggi siamo tutti più o meno concordi che il tv della realtà, fatta con persone più o meno comuni, si è incancrenita tanto da diventare un panem et circenses piuttosto desolante, un oppio dei popoli che offre intrattenimento a basso consumo intellettuale (per gli spettatori) e a basso budget (per le emittenti). Neanche gli ascolti ripagano più questa formula condita di scandali, amorazzi, vite private esplose e sbandierate, dinamiche da branco spesso e volentieri impazzito.
Un viaggio nel tempo
Ma questo documentario ci permette di tornare con la memoria a quel 14 settembre 2000, sera in cui per la prima volta il Grande Fratello accende le telecamere sulla casa più spiata dello schermo, dopo primi esperimenti passati in Olanda – dove il format è nato grazie a John De Mol e la sua Endemol – e in Spagna – anche lì per mano di Mediaset. All’inizio sembrava che nessuno volesse comprare e tantomeno vedere un programma in cui dei perfetti sconosciuti si annoiavano 24 ore su 24. Gli ascolti di quella prima puntata furono in effetti deludenti, tuttavia, come dice nello stesso documentario Daria Bignardi (giornalista scelta per condurre quell’esordio per via della sua allure intellettuale e per la sua lente antropologica), “fu una bomba che ci esplose in mano”. Il daytime che seguiva le vicende dei concorrenti giorno per giorno faceva ascolti da prima serata, la prima serata andava dal 40 al 60% di share (numeri da Sanremo, anzi da Nazionale di calcio), persino i nascenti provider di Internet – come Jumpy, sempre proprietà di Mediaset – venivano intasati da chi voleva votare, vedere, commentare. E poi giornali, imitazioni, tentativi di irruzione, discussioni in famiglia, feste popolari, statuine del presepe: un fenomeno totalizzante.
Il Grande Fratello era ovunque, così come ovunque erano i suoi protagonisti. Chi all’epoca era di fronte allo schermo può sciorinare a memoria i nomi dei dieci primissimi concorrenti, senza esitazione, quasi fossero i sette re di Roma o i colori dell’arcobaleno: Francesca, Roberta, Lorenzo, Sergio, Marina, Maria Antonietta, Rocco, Salvo, Pietro, Cristina (elencati, spero i più avvezzi lo notino, in ordine di eliminazione). Tutti tra i 25 e i 35 anni, giovani rappresentanti di un’Italia dalla varia umanità, tutti con la voglia di fuggire da una realtà più o meno stringente, erano anche pionieri veri e propri, disposti a farsi cavie di un meccanismo televisivo di cui non sapevano nulla, di cui quasi nessuno sapeva nulla. Nulla, soprattutto, si sapeva delle sue conseguenze: questi dieci sono entrati perfetti sconosciuti e ne sono usciti star assolute, inseguiti e idolatrati per strada, ricercati da agenti e promoter, strapagati (fino a 40 milioni di lire) per serate in discoteca o per i trenini di Buona Domenica.