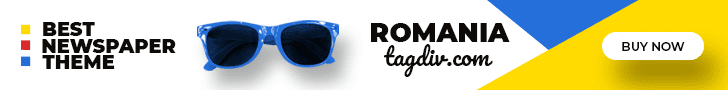Questo articolo è stato pubblicato da questo sito
Oggi il suo status di campione supera le prodezze in vasca e abbraccia un ruolo da ispiratore e ambasciatore: è intervenuto in diverse conferenze prestigiose a sostegno del movimento paralimpico, ha ottenuto riconoscimenti importanti, come l’Ambrogino d’Oro da parte della sua città natale. «È un ruolo che sento e che mi fa piacere. Ma è anche una responsabilità. Per me c’è differenza tra un vincente e un campione: il campione, oltre a vincere e a rendere al più alto livello, è anche un esempio fuori dall’ambito sportivo. Ecco perché mi sento in dovere di comportarmi nel migliore dei modi, per ispirare i bimbi e le bimbe con disabilità». La sua lunga lista di successi e record può, al tempo stesso, avvicinare tante persone allo sport paralimpico: «Chi ha cominciato a seguirlo se ne è poi innamorato», racconta Barlaam. «A volte può sembrare un mondo difficile per via del tabù della disabilità, ma lo sport paralimpico è sport e basta, con vincenti e sconfitti. Va guardato così, senza alcun pietismo».
I ragazzi italiani dell’acqua sono tosti, lo si coglie subito. Volano in vasca ma rimangono con i piedi per terra, orientano la loro vita al successo sportivo ma non tralasciano tutto il resto. Barlaam, per esempio, porta avanti i suoi studi di Ingegneria meccanica al Politecnico di Milano. Proprio come Manfredi Rizza, lui a 31 anni già laureato, con la magistrale in Ingegneria dei materiali conseguita nel 2020, un anno prima dell’indimenticabile argento di Tokyo. «Anni durissimi e bellissimi», dice. Dopo Rio, Rizza ha attraversato un momento che definisce «di transizione», quando ha rimesso al centro della discussione le proprie priorità: la canoa rischiava di passare in secondo piano per lasciare spazio agli studi. «È stato un periodo di ricerca, ho provato ad avere una vita normale, per capire cosa sarebbe successo. E poi ho colto: nella vita volevo fare il canoista». E allora non si è più fermato, ha capito che la vita era adesso, e che andava spremuta da ogni prospettiva. Soprattutto perché un’ossessione lo accompagnava come un’ombra: «Volevo a tutti i costi conquistare una medaglia olimpica. La volevo tantissimo, più di ogni altra cosa». Nel K1 200 metri, la sua gara, inserita per l’ultima volta nel programma olimpico, è arrivato un argento che luccica più di ogni altra cosa. «Nelle gare precedenti ero andato forte, ero in splendida forma, mi sentivo bene. Sapevo di aver fatto tutto il possibile per presentarmi a Tokyo nel migliore dei modi, e poi avevo già assaggiato l’ambiente olimpico, ero pronto anche dal punto di vista mentale. L’arrivo è stato, credo, il momento più brutto della mia vita. Una parte del mio cervello diceva “ce l’hai fatta”, un’altra mi invitava alla prudenza. E se poi non è vero? Sono stati secondi orribili, infiniti. Poi, quando ho visto il tabellone, è stata un’esplosione di felicità». Avercela fatta è un orgoglio, ma anche una manifestazione purissima di tenacia. «Lo sport mi ha insegnato l’importanza della perseveranza, il doversi prefissare ogni giorno un obiettivo. E poi ci sono stati i miei genitori, che per me sono un grosso punto di riferimento. Hanno avuto quattro figli e non è stato facile crescerci tutti, non gli abbiamo reso la vita facile (ride, nda). Mi hanno insegnato che nella vita bisogna sempre lavorare sodo, e che se hai delle capacità è opportuno sfruttarle al meglio».