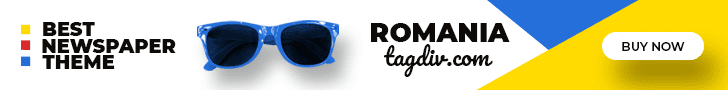Questo articolo è stato pubblicato da questo sito
Perché una relazione determina un confine tra due elementi in interazione, tra un essere umano e una stella, tra due stelle, tra due esseri umani. Pone “solo” un orizzonte, che però nel momento stesso in cui separa due elementi li mette in relazione.
Difatti, è l’orizzonte di un buco nero la nostra zona di contatto, ciò che ci permette di vederlo, di studiarlo, di determinarne comportamento e caratteristiche. In questo senso l’orizzonte ha quella forza di convinzione che il contorno a cinque punte di una stella ci dà per dire forte e chiaro “sì, questa è una stella” Ma non si tratta solo di una forza di convinzione relativa – “io qui vedo un buco nero” – bensì relazionale.
Infatti, quando guardiamo verso un buco nero, quando effettuiamo calcoli e misure per determinare tra noi e lui un orizzonte, ciò che disegniamo non è uno scorcio parziale di un oggetto al quale non possiamo girare intorno, e che offriva quella stessa, insoddisfacente, veduta anche prima che ci dessimo pena di guardarla. Al contrario, la prospettiva che creiamo in quell’incontro, per quanto non esaustiva, è veramente nuova, nel senso in cui è nuovo il valore dello spin di un elettrone nel momento in cui lo misuriamo, nel senso in cui è nuovo un quadro di Monet ogni volta che dipinge la stessa e identica cosa.
La relazionalità del mondo fisico è un’ipotesi che la meccanica quantistica permette di avanzare in virtù della costatazione che un elettrone ha uno spin, sicuro e scientifico, matematicamente e sperimentalmente verificabile, ma solo dal momento in cui viene misurato, solo dal momento in cui entra in relazione con un altro oggetto. Ma allora è solo quando i due oggetti si incontrano che l’un l’altro possono veramente dirsi oggetti, separati e separabili, proprio perché in relazione. Cosa diventano i confini, in questa descrizione relazionale?
Se due oggetti sono messi in interazione, le leggi della meccanica quantistica ci permettono di determinare, in qualsiasi momento successivo, lo stato globale dell’insieme composto da questi due oggetti. Ma non ci dicono nulla sullo stato di ciascuno, sullo stato dei confini, dei due oggetti. Gli stati dei due sottosistemi non possono essere distinti partendo dalla funzione d’onda che descrive lo stato globale. Non si può dire che ci siano due oggetti, finché per dirlo c’è bisogno che ciascun oggetto rimanga all’interno dei propri confini.
Al di fuori della loro relazione, i due – oggetti? – sono inseparabili, senza confini
È così che la misura di uno spin non cerca di determinare, di esperimento in esperimento “i contorni” di un elettrone, astratto e costante, indipendente da qualunque interazione. Non avrebbe senso. Perché, se quella misura ha valore, è proprio in quanto quantifica e definisce non l’elettrone astratto ma l’interazione, tra quell’elettrone e quell’apparecchio, che dà a entrambi identità.
Perché si può entrare in relazione solo con l’altro, con l’altro da sé. Ma si può essere sé solo in relazione, in quanto altro da qualcun altro. Cambia allora l’obiettivo. Dall’essere un modo per fissare i contorni delle cose – in maniera che scopriamo forse oggi essere insoddisfacente, perché al tempo stesso mette contorni anche alla nostra capacità di conoscere – la rappresentazione scientifica del mondo fisico diventa un modo per identificare, studiare, esprimere le relazioni, gli orizzonti, delle cose.
La domanda è una ed è sempre la stessa: come si disegna una stella? La domanda è se per disegnare una stella sia necessario tracciare confini tra di noi. Se per vedere le cose sia necessario dar loro dei contorni. Se sia possibile colorare fuori dai bordi, e descrivere il mondo fisico come un insieme di relazioni, senza confini.