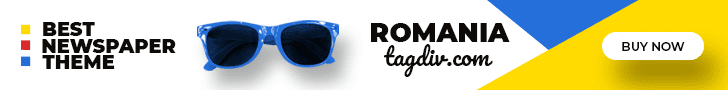Questo articolo è stato pubblicato da questo sito
Caffè amaro o caffè zuccherato? In Italia è qualcosa di più di una bevanda popolare. È un rituale sociale radicato, un fenomeno culturale che scandisce la quotidianità e socialità del Paese. Basti pensare come, solamente nei nostri bar, se ne stimi un consumo di 95 milioni di tazzine al giorno: oltre 30 miliardi di tazzine all’anno. Oppure come il mercato degli speciality coffee sia in continua crescita, in particolar modo tra i più giovani. Non si tratta però solo di una moda perchè c’è chi consuma il caffè anche per avere una spinta mattutina o per la serie di benefici per la salute (pare persino che possa proteggere dall’insorgere dell’Alzheimer) che molti hanno ipotizzato. Ma è, soprattutto, una questione edonica: ad alcuni intenditori il caffè piace amaro o acido; altri lo preferiscono edulcorato, vuoi con latte o zucchero; mentre le note aromatiche affascinano i più. Alla luce di un recente studio pubblicato su Food Chemistry da autori dell’Università Tecnica di Monaco (TUM), abbiamo ora più informazioni su come anche la genetica possa avere un ruolo.
Amore amaro
Checché se ne dica, anche se l’amaro è un gusto tipicamente respingente, nel caffè questa è spesso una qualità ricercata, perchè sinonimo di qualità. La caffeina è certamente il composto più conosciuto del caffè, nonostante contribuisca infatti solamente per circa il 10-30% dell’amarezza di questa bevanda, attivando ben cinque recettori (dei 26 totali) dedicati a questo gusto. A pensarci bene, infatti, anche il caffè decaffeinato è amaro: altri composti quindi contribuiscono al gusto amaro del caffè. Mentre la quantità di caffeina è pressocché la stessa nel caffè crudo o tostato, sono diversi gli altri composti amari che vengono sprigionati durante il processo della tostatura che avviene tipicamente a temperature sui 200 °C o superiori. È quindi la tostatura che, se usata sapientemente, valorizza il caffè rilasciando una serie di composti olfattivi e gustativi. Tra questi ultimi troviamo gli acidi clorogenici, i fenilindani o le dichetopiperazine che cambiano anche in base alla varietà, o cultivar, di caffè. Quanti siano in totale questi composti amari (decine, centinaia, migliaia?) e quali recettori amari attivino, non si sa ancora. Altri composti invece, come il mozambioside contenuto nella varietà Arabica che è circa 10 volte più amaro della caffeina e si lega a due (TAS2R43 e TAS2R46) dei suoi cinque recettori amari, vengono degradati dalla tostatura e non vengono più percepiti come tali, perchè ormai presenti in concentrazioni molto basse. Ma l’amaro può reincarnarsi in altre forme: l’anno scorso ricercatori della TUM avevano già identificato come dalla degradazione del mozambioside si producano per pirolisi sette composti, precedentemente mai individuati, che attivano gli stessi due recettori del loro precursore, talvolta anche in misura maggiore. Questi composti si trovano nel chicco tostato a differenti concentrazioni, in base sia alla temperatura sia alla durata della tostatura, ma si ritrovano anche nel caffè dopo la sua preparazione.
Scritto nel DNA
Una peculiarità di uno dei due recettori attivati da questi composti amari, il TAS2R43, è che non è in grado di funzionare in circa il 20% della popolazione europea. Ovvero: una mutazione genetica, meglio una delezione, ne impedisce il suo corretto funzionamento. Gli autori dello studio hanno quindi ipotizzato che coloro i quali non possedessero una versione funzionante di questo recettore avrebbero avuto più difficoltà a percepire il gusto amaro del caffè. Presto detto, così si è rivelato. La predisposizione genetica sembra quindi giocare un ruolo nella percezione amara di alcuni composti del caffè, la quale cambia di bocca in bocca e di tazza in tazza. Già qualche anno addietro, un gruppo di ricercatori dell’Ospedale infantile Burlo Garofolo e dell’Università degli Studi di Trieste aveva identificato come altre mutazioni genetiche a carico di TAS2R43 fossero associate al piacere verso il caffè. Lo stesso vale per mutazioni in altri geni dell’amaro, come TAS2R3, TAS2R4 e TAS2R5 che sembrano poter influenzare la percezione di parte dell’amaro dell’espresso.
Un caffè personalizzato?
Questi nuovi risultati aprono alla interessante possibilità di sviluppare caffè personalizzati in base alle proprie preferenze gustative e predisposizioni genetiche. In un futuro non così lontano lo si potrebbe fare lavorando su di una tostatura coordinata che faccia emergere, o meno, alcuni composti amari, anche a seconda della cultivar di partenza. Ancora, questa scoperta potrebbe anche aprire nuove opportunità di ricerca su possibili nuovi benefici sulla salute. Questo perchè gli stessi recettori dell’amaro che abbiamo sulla lingua si ritrovano anche in altre parti del corpo (chiamate extra-orali), quali polmoni e tratto gastro-intestinale, dove svolgono funzioni molto importanti: supporto all’immunità; incremento della sazietà; sviluppo della motilità intestinale. Considerato che il caffè contiene una abbondanza di composti bioattivi, come stimolanti e antiossidanti, molti dei quali sono amari, avere una conoscenza più completa di quali composti attivino quali recettori potrebbe aiutarci a sviluppare proposte sempre più personalizzate con benefici aggiuntivi, non solo legati al gusto.