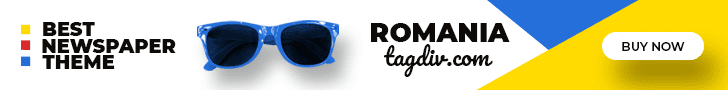Questo articolo è stato pubblicato da questo sito
Lo sviluppo personale, in effetti, è il grande tema del romanticismo. Inizia tutto alla fine del Settecento, quando in concomitanza con la Rivoluzione francese alcuni intellettuali iniziano a definire le caratteristiche dell’individuo moderno. Nel suo ciclo di romanzi sul personaggio di Wilhelm Meister, Goethe racconta le peregrinazioni di un uomo alla ricerca della propria vocazione: nella filosofia successiva, questo lento apprendistato prenderà il nome di Bildung. Hegel parla del bisogno umano di riconoscimento. Il tema dello sviluppo personale è consustanziale al nuovo ordine che stava nascendo dalle ceneri dell’Antico Regime, dove i ruoli di ognuno erano fissi e immutabili; nella società liberale, invece, ognuno ha l’onere di trovare il proprio posto nel mondo per perseguire – come dice la Costituzione americana – la “conquista della felicità”. Cosa potrebbe andare storto? Beh, innanzitutto si dovrà fare i conti con la delusione di tutti coloro che non ce la faranno.
A metà del secolo, Kierkegaard descrive l’incapacità di realizzarsi – o peggio la non volontà di farlo – come una “malattia mortale”, la disperazione. Poco a poco, ci si accorge che la società moderna oppone innumerevoli ostacoli allo sviluppo personale. Il tema, centrale nel teatro di Ibsen, tornerà alla moda in pieno Novecento, negli anni del Boom, quando un anziano sociologo tedesco impregnato di romanticismo trova la chiave per impacchettare questa materia incandescente in un agile best-seller: il vegliardo è Erich Fromm e il libro Avere o essere, praticamente il prototipo di tutto il self-help a venire. In quelle pagine, il sociologo assegna all’individuo moderno una missione titanica: essere.
Ma tra la vita reale e la vita sognata c’è di mezzo un mare. Come realizzare un ideale essenzialmente borghese nell’epoca della società di massa? Come “essere”, caro Erich, in una società che ci indica soltanto vocazioni irrealizzabili, perché i posti sono tutti già occupati?
Rileggiamo con attenzione il verso della seconda Ode pitica. Pindaro scrive, alla lettera: “Diventa quello che hai imparato a essere”. Letto oggi, il verso attira la nostra attenzione su quanto è difficile, sul mercato del lavoro, approdare a un’occupazione che corrisponda all’educazione che abbiamo ricevuto. Non è infatti l’educazione – la Bildung, direbbero i romantici – che ha fatto di noi quello che siamo? E cosa succede agli individui e alla società quando nessuno riesce più a diventare sé stesso? Oggi, a causa di un virus culturale incredibilmente contagioso, la malattia mortale di Kierkegaard è diventata una pandemia. Così la ricerca della felicità approda alla conquista dell’infelicità.
Il fenomeno fuffaguru
Ecco insomma da dove nasce l’ampia domanda dei fuffaguru: dalla promessa (irrealizzabile) da cui sorge la civiltà moderna. E di tutta evidenza non sarà Maicol Pirozzi a salvarci. Nessun talk motivazionale, nessun workshop, nessun mentoring – nemmeno la mindfulness e il reframing mentale – basteranno a risolvere la contraddizione fondamentale della modernità, tra la promessa di auto-realizzazione e un’organizzazione della vita che annienta ogni margine di autonomia e di creatività. Oggi iniziamo a sospettare che diventare sé stessi sia praticamente impossibile; ma nel dubbio continuiamo a spendere tutte le nostre energie per farlo.