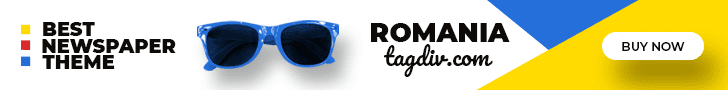Questo articolo è stato pubblicato da questo sito
Oggi esiste uno smartwatch che monitora i parametri vitali degli alberi. Una tecnologia che, all’interno del progetto #RigeneraBoschi di Sorgenia, ha permesso di evidenziare che gli alberi inseriti in interventi selvicolturali calibrati siano più resistenti allo stress del cambiamento climatico. Questi risultati arrivano dal primo anno di raccolta dati dei cosiddetti Tree Talker, ovvero sensori posizionati sugli arbusti, che sono al centro del progetto. #RigeneraBoschi è una ricerca in corso, coordinata dal professor Giorgio Vacchiano della Statale di Milano, condotta in cinque boschi italiani. La ricerca andrà avanti almeno fino a settembre 2026, ma potrebbe essere prolungata.
I boschi che fanno parte del progetto
Come detto in precedenza, il progetto comprende cinque boschi: il parco Nord Milano, il bosco di Forlì-Bertinoro dell’Istituto Diocesano sostentamento clero in Emilia-Romagna, il Parco naturale regionale Bosco Incoronata in Puglia, il Parco nazionale del Pollino, situato in un territorio tra la Calabria e la Basilicata, e l’Unione dei Comuni Montana colline metallifere in Toscana, i cui dati devono ancora essere raccolti perché la gestione selvicolturale avviene a novembre.
La gestione dei boschi è come una medicina preventiva
In ogni bosco, individuato insieme a Pefc Italia, viene fatta una comparazione tra un’area dove le piante crescono libere e una dove invece vengono portati avanti interventi mirati, gestiti in modo sostenibile. Quattro i principali indicatori tenuti sotto osservazione: accrescimento del diametro, stabilità meccanica, flusso linfatico e attività fotosintetica della chioma. Prendendo i primi due parametri, in quattro boschi su cinque quelli “gestiti” crescono meglio rispetto a quelli lasciati in libera evoluzione.
Durante le oltre settemila ore di monitoraggio è stato evidenziato come la gestione possa essere una sorta di medicina preventiva per il bosco: nel parco nazionale del Pollino si parla di un +43% su base annua. L’unica zona in controtendenza è quella del bosco Incoronata, in Puglia. “Tutto dipende sempre dalla storia del bosco – precisa Vacchiano – in quell’area c’è la presenza dell’eucalipto, che non è una specie nativa, ma è molto infiammabile. Lì la gestione, essendo una zona ad alto rischio incendi, è sempre stata caratterizzata dal diradamento, con lo scopo di prevenire gli incendi. Si mette in atto una sorta di distanziamento degli alberi in modo che il fuoco passi più difficilmente da una pianta all’altra e sia più facile da spegnere. Nella parte non gestita non ci sono eucalipti, presenti invece nella parte gestita. Anche se noi monitoriamo le querce, possiamo notare che gli eucalipti competono a livello idrico”. Questo potrebbe comportare, ad esempio, una minore crescita delle querce causata dalla competizione per le risorse ma i segnali sono ancora in fase di analisi.
Il flusso linfatico varia in base al contesto
Il flusso linfatico, che potremmo definire il “sangue circolante” nei boschi, monitorato dai sensori, rivela variazioni importanti in base al contesto. Lo stress idrico, soprattutto nelle zone più esposte al caldo del cambiamento climatico, nei territori a bassa quota, comporta livelli meno costanti e una maggiore vulnerabilità alla siccità.
Evidente quanto siano diverse le situazioni anche guardando il parametro della luce e della fotosintesi, che in generale ha livelli simili tra le due aree (gestita e non). Nel caso specifico della zona di Forlì, però, l’eccessiva apertura del bosco gestito rende il parametro migliore in quello non gestito, dove c’è più ombra.
Un monitoraggio costante permette azioni mirate per i territori
Tutti i dati, anche quelli che in prima battuta potrebbero sembrare negativi, in realtà si rivelano utili nel momento in cui si renda necessario programmare nuovamente gli interventi. Un monitoraggio costante permette infatti azioni mirate e pensate per quel territorio specifico, impossibili senza questa tecnologia che permette una raccolta massiccia di dati. “Abbiamo identificato aree con una pianificazione. Prima potevamo solo osservare, ora, invece, abbiamo anche i dati sulle tendenze. Questo è importante perché la gestione delle attività permette un approccio multifunzionale che comprende quindi la tutela della biodiversità, il turismo o la produzione del legname” precisa Antonio Brunori, segretario generale di Pefc Italia.