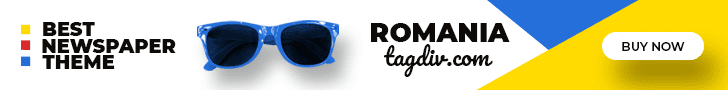Questo articolo è stato pubblicato da questo sito


La moda, quando agisce al meglio delle sue possibilità, immagina umani e mondi alternativi, auspicabili o distopici che siano. Per questa ragione, nel corso del ’900 sono innumerevoli le occasioni in cui i designer hanno flirtato con immaginari letterari ed estetici, tanto di ricerca quanto spudoratamente pop, che in forme diverse hanno esplorato ipotesi attigue.
La scienza (intesa sia come disciplina che come “estetica della scienza”) e la fantascienza hanno avuto un ruolo centrale in questi confronti. Dagli anni ’50 e ’60, in cui l’impatto e la rilevanza dei programmi di esplorazione spaziale hanno dato vita a un intero stile che ha preso il nome di Space Age, grazie al lavoro di creativi come Rudi Gernreich, André Courrèges, Paco Rabanne e Pierre Cardin, passando alla fascinazione cibernetica e cyberpunk degli anni ’80, fino alle sperimentazioni e alle ibridazioni sui materiali e sulle tecnologie indossabili e applicabili ai capi su cui tuttora si lavora ampiamente.
Fino a solo qualche stagione fa, questo tipo di ricerca si rifletteva in una presenza variabilmente massiccia ma sempre riscontrabile di collezioni o singoli capi che manifestavano in maniera chiara e visibile l’idea del corpo futuro come corpo cyborg, come organismo cibernetico, citando i due termini da cui deriva la parola macedonia.
La settima arte, dai B-movie apocalittici e proto-horror degli anni ’50 e poi con l’enorme quantità di titoli spaziali e sci-fi dei ’60, l’inquietudine extra-terrestre e organico-colonialista di filoni come Alien e poi epopee cyborg vere e proprie come Blade Runner, Terminator o RoboCop, ha dimostrato quanto il tema sia stato oggetto culturale di larghissimo consumo e di successo commerciale per decenni.
Thierry Mugler è stato forse il designer che più di tutti e con una pervasività pop capace di entrare nell’immaginario collettivo come nessun altro, ha fatto proprio il ruolo del cyborg, rielaborandolo in forme diverse in un susseguirsi di collezioni, dalla versione lussuosa e decadente, potenziata e muscolare delle tute di Star Trek della metà degli anni ’80, agli androidi ipersessualizzati in plexiglas e metallo degli anni ’90, in cui i corpi diventavano superfici lisce e riflettenti e non senza ironia la pelle diventava carrozzeria.
Negli anni ’90 Alexander McQueen si spinge con le sue messinscene teatrali verso derive inquietanti e tragiche, in cui il corpo e la macchina si straziano a vicenda. E dove l’umano è costretto a fare i conti con l’altro lato dell’industria, fatto di rifiuti, scorie e liriche contaminazioni batteriche o nucleari.