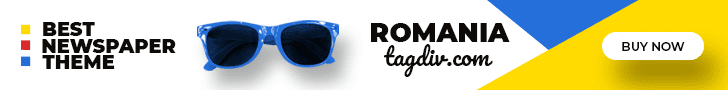Questo articolo è stato pubblicato da questo sito
Ferie d’Agosto nel suo piccolo, ha segnato un momento di svolta nella rappresentazione della famiglia, questo mostro che domina la nostra cinematografia da decenni, nel bene e nel male. Ma ciò che fece Paolo Virzì in quel 1996, fu anche delineare un racconto che tra risate amare e riflessioni, fungesse da sintesi di ciò che era la società italiana di quegli anni, divisa tra destra e sinistra, ricchi e poveri, consumismo e ipocrisia di una vita fatta di rimpianti e infelicità. Riguardare questo film, ora che arriva il sequel, è un vero tuffo più nel presente che nel passato.
Due famiglie divise da tutto nell’estate del 1996
Ferie d’Agosto torna con questo sequel, Un Altro Ferragosto, che di certo si porta dietro una bella dose di curiosità e di aspettative, visto che il film che uscì in quell’estate del 1996, fu capace di segnare quasi un’epoca. Paolo Virzì rinnovò la struttura della commedia popolare italiana, ma allo stesso tempo recuperò tematiche profonde e attuali come quella della fuga, che aveva portato Gabriele Salvatores a concepire una filmografia ampia, sublimata dall’Oscar per Mediterraneo, atto finale della sua iconica tetralogia sulla fuga. Vi era però anche per forza un connettersi al ciclo dei cinepanettoni, all’idea di vacanza come evasione e volontà di riscatto da esistenze piatte e senza speranza per cercare la felicità. Qui in fondo è la stessa cosa: famiglie strane e variopinte, una località balneare, la volontà di cambiare tutto.
La sua identità era però strettamente connessa giocoforza anche al berlusconismo. Inutile negarlo, presso l’isola di Ventotene, la famiglia capitanata da Sandro Molino (Silvio Orlando) e quella che segue Ruggero Mazzalupi (Ennio Fantastichini) sono due universi contrapposti da una visione della vita e della società, che è metafora dell’Italia che si divide tra chi seguiva il Cavaliere di Arcore e chi invece il variopinto e disgregato mondo della sinistra. Il che fa di Ferie d’Agosto anche un film dagli echi morettiani, per la sua capacità di unire alto e basso, società, politica e costume, con un sarcasmo impietoso ma mai gratuito. Ma soprattutto, Ferie d’Agosto è stata una commedia capace di essere universale al di là della particolarità dei singoli personaggi, eventi e dinamiche, nonché uno dei film migliori di quel periodo per il nostro cinema più popolare.
Virzì si era presentato in gran spolvero con un film molto più serio: La Bella Vita, uno dei titoli italiani migliori dei primi anni ’90, capace di farsi interprete del difficile momento che l’Italia stava vivendo, con la mutazione dei valori e la crisi della classe operaia. Ferie d’Agosto è attinente anch’esso al concetto di crisi, ha infatti lo stesso sapore agrodolce che poi avrà il mondo di Virzì nel bellissimo Ovosodo, il punto più alto del regista in carriera, nonché forse la miglior commedia italiana del decennio. Quel 1996, intanto vedrà anche la sconfitta di Berlusconi alle elezioni di lì a pochi giorni dall’uscita del film in sala, in un aprile in cui è Romano Prodi con il suo Ulivo a spezzare il mito dell’invincibilità del Cavaliere. L’Italia però è divisa da qualcosa di più profondo dalla mera politica, perché con Berlusconi avanza anche una visione della vita, della società, che proprio Mazzalupi, “generone” romano, vitellone infido, opportunista e la sua combriccola rappresentano in pieno.
Ruggero è un uomo arrogante, manipolatore, volgare, che brama di poter lasciare la moglie Luciana (Paola Cruciani) per la sorella di quest’ultima: Marisa (Sabrina Ferilli), sposata con il debole e infantile Marcello (Pietro Natoli). Sono individui casinisti, superficiali, cafoni, prepotenti e consumisti. Ma sono anche pieni di una sensazione di sconfitta, di incapacità di arrivare alla felicità, quasi opprimente. Molino d’altro canto ha un rapporto conflittuale con diversi membri della sua famiglia allargata, composta tra gli altri dalla compagna Cecilia (Laura Morante), l’ex compagno di lei Mauro (Silvio Vannucci), la loro figlia Martina (Agnese Claisse), la coppia gay Betta (Raffaella Lebbroni) e Graziella (Claudia della Seta) e l’eterno ribelle Roberto (Gigio Alberti). Sono colti, progressisti, anelano una spiritualità e alternatività che è spesso mera forma, motore di una certa arroganza. Si sentono però anche irrisolti e incapaci di lasciarsi il passato alle spalle.
Più che un film, una profezia amara sulla nostra società
Ferie d’Agosto usava il pretesto di un incidente causato da Ruggero verso un extracomunitario per creare una riunione, da cui cominciava una contrapposizione tanto elementare ed istintiva, quanto in realtà foriero di un rovesciamento totale. Sì, perché sono Ruggero ed i suoi a cercare di appianare ogni divergenza e creare un clima di convivenza, così come avevano cercato anche di legare con quegli strani fricchettoni, in nome di una comune italianità, anzi romanità. Sono però anche rozzi, superficiali e incapaci di un minimo di sensibilità verso il prossimo. La discussione sarà solo l’inizio di un iter di profonda crisi personale per ognuno dei protagonisti, a dispetto di sesso ed età, con cui cercare di fare i conti con errori e dolori, desideri inconfessabili e rimpianti. Da questo punto di vista, la scena della stella cadente, con tutti i personaggi che esprimono desideri tra i più vari, strani e irrealistici, è una perfetta disamina dei valori di ognuno, del loro rapporto con la realtà del loro quotidiano.
Il confronto che Virzì mette in atto è dove i luoghi comuni, i dialoghi stereotipati non sono causali, ma in realtà lo specchio di ciò che succedeva (e succede) nella società italiana di allora, dove la contrapposizione si è fatta feroce perché connessa ad una politica che cessa di essere contenuto, diventa slogan, parola d’ordine, il tutto e il niente. Questi due gruppi sono in realtà identici nell’intolleranza, nell’egoismo, nell’ipocrisia con cui nascondono sotto il tappeto verità, sentimenti, problemi ed errori. Qualcosa che Virzì utilizza per delineare il mutamento sociale ma anche anticipare la realtà italiana. Del resto il suo non è un cinema di mera contemporaneità, ma anche di analisi di tendenze e comportamenti, visione profetica per quanto addolcita da quella giocosità e quell’affetto per l’umanità che non ha mai rinnegato.