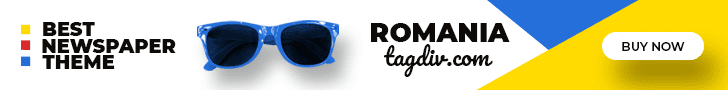Questo articolo è stato pubblicato da questo sito
1899 su Netflix sta attirando l’attenzione di parecchi spettatori: negli ultimi giorni tantissimi stanno guardando questa serie che sfugge a ogni definizione univoca ed è tra l’altro recitata in una decina di lingue diverse. Di sicuro è la curiosità e il passaparola che sta attirando il pubblico a mettersi di fronte a questo enigma indecifrabile ma in molti l’hanno già condannato senza appello: non si capisce niente, è la solita serie inutilmente complicata, io-no-che-non-mi-faccio-fregare-ancora. 1899 è la nuova cosa che o si ama o si odia, come il coriandolo, il Piccolo principe e l’ora solare. Da una parte chi se ne tiene alla larga ha le sue ragioni anche comprensibili – un misto di sfinimento e diffidenza – ma dall’altra è davvero un gran peccato che una sfida narrativa di questo tipo non venga affrontata con il giusto atteggiamento, cioè con curiosità, pazienza e un pizzico di rassegnazione.
Twitter content
This content can also be viewed on the site it originates from.
Del resto 1899 ha tutti i presupposti per triggerare l’impazienza dello spettatore medio: cambia genere e registro ogni secondo, prima è horror, poi è dramma, poi è soft porno gay, poi è fantascienza, poi di nuovo horror, poi Titanic, poi Matrix e così via; è recitata in mille lingue quindi i sottotitoli sono inevitabili; i dialoghi sono sempre un po’ allusivi ma lasciati a metà e nessuno sembra formulare frasi sensate; ha una colonna sonora che neanche al porto di Marghera; le domande si affastellano una dietro l’altra (Perché la cinese è vestita da geisha giapponese? Chi ha addestrato lo scarafaggio a scassinare le serrature? Chi ha costruito quel gioco del quindici ma coi triangolini? In che ufficio postale è andato chi ha mandato le lettere ai passeggeri che vivono a ogni angolo del pianeta?) e il finale è una delle cose più WTF mai viste negli ultimi anni. Eppure è difficile abbandonare la convinzione che tutte queste cose, più che essere vissute con fastidio e nervosismo, dovrebbero essere invece prese come sfide avvincenti. “Che diavolo succede poi?” o “Perché mi hai raccontato tutto ciò?” sono i quesiti fondamentali della letteratura fino dai tempi di Gilgamesh.
Io quelli che vogliono buttare il tablet dalla finestra ogni volta che ci sono storyline multiple, flash-forward, bambini inquietanti con carenza di ferro o nefasti marchingegni a forma di piramide però un po’ li capisco. Si chiama la sindrome di Lost. Dopo che per sei stagioni siamo stati ostaggio di J.J. Abrams e dei suoi orsi polari, dei numeri di pseudo-Fibonacci, dei salti temporali e delle nubi nere che ti spicciano casa per poi arrivare alla fine e scoprire quello che sospettavamo fin dalla primissima puntata (cioè che erano – spoiler! – tutti dannatamente – ho detto: spoiler! – morti stecchiti), è comprensibile che qualsiasi progetto narrativo che cerchi di fare il furbo alterando la linearità e moltiplicando gli spunti mistici e i colpi di scena fa drizzare subito le antenne. Esistono talmente tante serie al giorno d’oggi che forse non abbiamo voglia di farci intortare ulteriormente: Emily in Paris, per dire, sta sempre a Parigi a farsi i selfie, non è che un giorno entra in un café a Places de Vosges e si ritrova nella Tokyo del 1765 ad allevare cormorani a testa in giù.