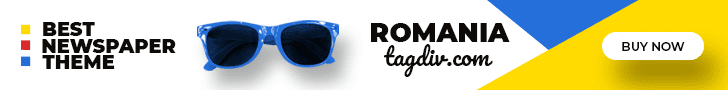Questo articolo è stato pubblicato da questo sito
C’è poi la questione Gdpr. Dietro a questo acronimo c’è il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, lo strumento introdotto dall’Unione europea per tutelare la privacy. Approvato nel 2016, è entrato in vigore dal 2018 con l’obiettivo di dare ai cittadini il controllo dei loro dati nel mondo fisico e in quello digitale. È stato di ispirazione in altri paesi, dal Giappone al Brasile, ma secondo i suoi critici tra il mondo ideale e quello reale nella continua evoluzione tecnologica il Gdpr inizia a mostrare limiti. ChatGpt ne è solo l’ultima prova.
Nell’Unione europea la complessità del Gdpr e il modo in cui viene applicato possono essere un freno per l’innovazione e la competitività in settori come l’internet delle cose, l’intelligenza artificiale e perfino la sanità. Pur non rinnegando il Gdpr, la Commissione europea si è accorta del problema. Da quando si è insediato, una delle ossessioni del commissario al Mercato interno Thierry Breton è quella di “sbloccare i dati”. Perché, tra burocrazia e paura di multe, i dati circolano troppo poco nell’Unione europea. Per aggiustare alcuni effetti indesiderati del Gdpr e accelerare la transizione digitale, la Commissione ha presentato diverse proposte, senza mettere in discussione il principio base: l’utente deve poter avere il controllo dei suoi dati. Si pensi alla legge sui dati del febbraio del 2022 che facilita la circolazione dei dati industriali, con particolare attenzione ai prodotti connessi. Il volume dei dati nell’Unione europea è infatti in costante crescita. Secondo la Commissione, se nel 2018 sono stati generati 33 zettabyte, per il 2025 sono previsti 175 zettabyte.
Dal settembre 2023 potrà poi essere applicata la legge sulla governance dei dati per facilitarne la condivisione nel rispetto della privacy dei cittadini. E i campi di applicazione sono tanti, dalla mobilità alla medicina con miglioramento delle loro performance. Un po’ come accade per le tecnologie quantistiche che hanno un impatto reale sulla nostra vita quotidiana. Parliamo di infrastrutture sostenute dalla rete Euro Hpc (un progetto europeo da 7 miliardi) al servizio di qualsiasi tipologia di ricerca che possa essere trasformata in una simulazione.
In questo modo funzionano di fatto i supercomputer, come il pre-exascale Leonardo del Tecnopolo di Bologna, sono macchine che possono essere impiegate negli studi climatici e persino nel miglioramento della prestazione di una tavola da surf. Inoltre, tra gli argomenti più caldi di questa Digital Assembly c’è senza dubbio l’Eu digital identity wallet. La priorità è ora definire la cornice legale, spiega Roberto Viola, a capo della Direzione generale Connect della Commissione europea, che ha annunciato la presentazione dell’architettura dell’intero progetto nelle prossime settimane. Sono stati inoltre già stanziati 15 milioni di euro per permettere a cittadini pilota di testare il servizio e avere una panoramica sull’efficacia e sui punti deboli su cui lavorare.